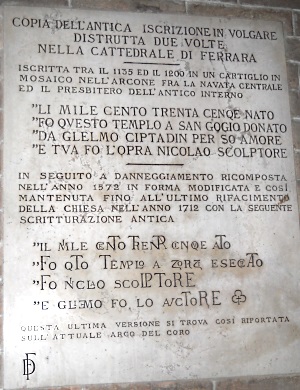(di Stefano Termanini)
N.B. Questo racconto è un omaggio a Raffaele La Capria, maestro insuperabile di scrittura, che guarda alla letteratura italiana dall’alto del suo centesimo anno d’età. Ed è una riflessione sulla guerra, che uccide la vita e il suo sogno. Voglio sia dedicato ai miei allievi di Boston University CIES, Padova: sono sparsi per il mondo. Spero siano intenti a far crescere i loro sogni e a coglierne il frutto.
Leggi l’articolo o (se preferisci o ti è più comodo) ascolta il podcast:

La neve e la guerra
Arrivati a quel punto, ci potevamo considerare amici.
Insieme avevamo passato i rigori dell’inverno e quello di Padova può essere crudo. Loro, sia quando pioveva pioggia gelida sia quando nelle cunette, a lato delle strade, si accumulava la neve fradicia, mi arrivavano in aula vestiti di niente, perché a casa loro usava così. Il lunedì avevano sonno. Se c’era confidenza – e il più delle volte c’era – si lasciavano andare a raccontarmi di Venezia, Firenze, Roma e di quanto gli fosse piaciuto visitarle nel finesettimana. Ad aprile eravamo stati sui Colli Euganei, a visitare la casa del Petrarca.

Per solito, ogni volta che si organizzava quella gita, il tempo era brumoso o addirittura pioveva (ma capitò una volta che sembrasse già quasi estate e tutte le piante del giardino del Petrarca, piante che a loro e a me parevano vecchie come i muri stessi della casa e la sua gatta, fossero fiorite). A maggio, poi, il tempo girava di colpo e i tetti sfavillavano e un profumo rosso tingeva il cielo quando, alle otto, cominciavano le lezioni e tutto diventava azzurro appena un’ora più tardi e mi pareva che la Cappella degli Scrovegni, con due colpi d’ala, potesse circondarsi di cielo e avvolgersi di blu, proprio così come Giotto aveva immaginato che accadesse e come l’aveva dipinta, là dove, leggera quasi fosse di balsa, a mezz’aria, Enrico Scrovegni l’offriva alla Vergine.

Secondo gli anni, a fine maggio poteva essere già quasi estate. Si andava in giro in camicia, a maniche arrotolate, e in certi mezzogiorno canicolari ci si rifugiava sotto i portici di via San Francesco o si sboccava nella frescura del Prato della Valle. Il pomeriggio il sole aveva fatto levare in quella nostra parte di città l’odore terroso dei mattoni e il verde amaro dell’edera. Era allora che a me veniva voglia di parlare di neve. Chiamavo il mio studente migliore e, chiedendo a tutti di seguire sui libri che avevamo distribuito a due a due, lo pregavo di leggere. «Inizia da qui», gli indicavo sul testo, e posavo la punta dell’indice su quelle tre parole con cui la pagina cominciava: «lontano prodigioso giorno». Lui (ma più spesso era lei) prendeva a scandire da quel preciso punto, con il suo traballante e sonoro accento americano: «In un lontano prodigioso giorno del 1939 i ragazzi che giocavano nel cortile del Palazzo Donn’Anna, a Posillipo, affacciandosi dai tre archi sul mare videro con sorpresa la cima del Vesuvio tutta coperta di neve». Arrivato a “neve”, il mio studente (o la mia studentessa) prendeva un piccolo respiro, mi alzava una breve occhiata d’intesa, quasi a dirmi che ce l’aveva davanti quel Vesuvio imbiancato e il mare azzurro e le arcate e il palazzo antico, dove i ragazzi giocavano. E poi la neve: era una bella idea quella della neve in una giornata così, col ronzio degli insetti, già grassi di primavera, che giungeva, senza che l’accompagnasse nemmeno un filo d’aria, di là dal il quadrato della finestra aperta. Facevo un cenno. Volevo dire che ce l’avevo davanti anche io.

Andasse, dunque oltre: «Il Vesuvio non pareva più il Vesuvio con quel capriccio bianco, era fantastico, lieve e librato come un miraggio nella trasparenza azzurrina dell’aria». Qualcosa sarebbe accaduto, era chiaro. Ma il Vesuvio non era già, di per sé, abbastanza magico? Non gli bastava, al Vesuvio, d’essere così com’era, cono di roccia sopra la città, dio protettore e pendolo del suo destino? «Ci siete stati a Napoli?», interrompevo per un momento la lettura – cercavo di farlo il meno possibile, ma, quando capitava, lo facevo perché tutti potessero seguire e qualche volta anche perché, quando insegnavo, più di quanto avrei voluto, mi lasciavo prendere dall’emozione. Ciondolavano le teste. Due o tre facevano di sì. Uno diceva che suo nonno era napoletano. «Bene», dicevo io. Per molto tempo, forse anche oggi, Napoli è stata più famosa di Washington – e io credo a ragione. Ma per chi viene dall’Arkansas non è obbligatorio sapere come sia e dove e che cosa rappresenti, per Napoli, un destino guancia a guancia con la montagna.

«A Napoli – lo dico per chi non c’è stato – c’è il Vesuvio. Un vulcano. Ogni qualche anno il Vesuvio fuma, ogni mille anni scoppia. Avete letto di Pompei e di Ercolano? Ecco, quella volta, duemila anni fa, era il 79 dopo Cristo, il Vesuvio scoppiò. In poche ore due città furono sepolte dalla cenere e tutti vi morirono. Fu come una bomba, che, però, lasciò ogni cosa intatta. Chi c’è stato, chi le ha visitate, ha visto: case e affreschi, mosaici, strade, i corpi addirittura delle persone che la nube di fuoco travolse. Ora, immaginatevi che cosa sia vivere tutta la vita con accanto quel mostro. Tu sai che potrebbe risvegliarsi e ucciderti: te, i tuoi figli, i tuoi amici. Che in un momento, senza lasciarti il tempo di accorgertene, potrebbe cancellare la tua vita, la tua città, la storia tua personale e quella di tutti i tuoi amici. Tutti insieme, come formiche, con un colpo di spugna. E tu, se sei di Napoli, questa cosa la sai dal tuo primo giorno e tanto la sai – tanto sai che in un momento il Vesuvio che sta sullo sfondo della tua vita, lontano e prodigioso, potrebbe ucciderti – che ti ci abitui e, vedendolo ogni giorno, di giorno in giorno, cominci ad amarlo quel tuo Vesuvio… E lo ami proprio perché sai che potrebbe ucciderti e che non lo fa e, se non lo fa, vuol dire che in fondo ti vuole bene e tu gli vuoi bene perché lui te ne vuole. Eppure è lì, alle tue spalle quando vai al mare; lo vedi dalla finestra quando sei seduto a tavola e ti godi una di quelle buone pizze che sanno fare soltanto a Napoli. Vai a spasso, giri per il corso, fai le spese. Vedi le navi che entrano in porto, le crociere piene di turisti l’estate, le barchette dei pescatori la mattina presto, quando ti chiamano per il tuo primo lavoro e devi correre in stazione che è ancora l’alba. Se sei di Napoli, ci passi tutta la vita accanto. Cresci, vai a scuola, ti innamori, metti su famiglia, vedi nascere i tuoi figli – e il Vesuvio è lì davanti a te e, tanto quanto lo vedi tu, lo vede accadere anche lui tutto questo e lascia che accada proprio quando potrebbe, invece, con un suo scoppio soltanto, impedirlo. Lo ami tanto, a un certo punto, che è come se si fosse cambiato con te stesso e con il tuo destino: non è lui, non è te, non è la tua città, ma di sé, di te, della tua città è, a un certo punto, come se fosse un pezzo d’anima. Sì, ho detto anima: soul. A piece of your soul».

Accenno a Mary (quella è la sua volta): «Tonino gridò…» riprende a leggere lei. «“Guardate! Guardate la neve!”». Andiamo avanti. La novella racconta dei ragazzi e dei loro giochi: George, il piccolo Goody, così facile alle lacrime, e sua sorella Margaret, che lo consola. Mary, mentre legge, si attorciglia un ricciolo attorno all’indice della mano sinistra, con la destra tiene aperte le pagine del libro davanti a sé, mentre i personaggi del racconto si svelano, uno dopo l’altro, e i miei studenti stanno a capo chino, assorti e non c’è nessuna parola difficile che io debba chiosare, ma il ritmo soltanto delle frasi di Raffaele La Capria, niente più che la ritmica purezza delle sue frasi. Mary legge, seduta in basso, distesa, placida nel suo corpo di donna ancora acerba, così com’è serena e mobile nel suo spirito. Susan alza gli occhi verso la finestra, distratta dallo strido di una rondine. «Geooooooooorge! Come up stairs!», legge Mary, e tutti accennano a un sorriso. Nel racconto i ragazzi si dividono, la madre – la signora Marshall – li richiama a casa e loro risalgono, «come soldati obbedienti a uno squillo di tromba». Restano nel cortile Tonino, a cui piace tenoreggiare l’aria di Fra’ Diavolo che ha sentito nel film di Stanlio e Ollio, Pallino, capace di correre a testa bassa e gettarsi nella mischia, Benito, Pepito, Berto che aveva il piede prensile e tutti chiamavano per questo “Bertuccia”, e sua sorella Eddì, svagata e ignara della bellezza misteriosa del suo sorriso appena allora fiorente e dei suoi capelli legati in trecce; biondi del colore del miele freddo, come diceva Malaparte scrivendo del color biondo delle napoletane. E Mary va avanti a leggere, senza cambiar posa a un muscolo, con la mano destra che scorre lungo la pagina e l’accarezza. «Dai tre archi a picco sul mare tiravano sassi alle barche, scendevano giù alla banchina a pescare i gamberi e i granchi tra gli scogli verdi e scivolosi d’alghe e le grotte invase dall’acqua, si inseguivano nei recessi – “recesses, angles, parts” dicevo io – più segreti del palazzo che nei piani inferiori, quelli sotto il cortile e al livello del mare, era abbandonato e in rovina». E’ l’ultima lezione e a me e a loro piace addentarci nella fiaba della moglie di un viceré di Spagna, una donna corrotta e lasciva, che seduceva i marinai e li uccideva, con la freddezza di una mantide, e tornare poi alla visione del Vesuvio spolverato di neve, con quella sua luce «chiara ed esatta che azzerava l’azzurro all’orizzonte». Mary legge e noi guardiamo oltre la finestra, dove api e bombi si azzuffano e il ronzio è così intenso che pare ora un mezzo sibilo. «Chissà quando e in quale anno futuro sarebbe ricomparsa una neve così! E chissà quanto sarebbe durata questa!».
Guardo l’orologio (“quanto sarebbe durata? quanto durera?”). L’orologio, perché è già passata mezz’ora, e il calendario, alle spalle di Ron, con il segnagiorno rettangolare magnetico, rosso, appicciato a quel lunedì di fine maggio. Gran traditore, il tempo! Tra circa due ore – penso – il corso di letteratura medievale lo finirò leggendo la canzone 359, quella in cui Laura ricompare in sogno al poeta e gli dice che la sua bellezza è svanita, così come la sua vita, ma che un’altra bellezza, dentro di lei, resiste. Non sarà allegro, penso. A modo suo, però, un messaggio di lietezza quel sogno se lo porta dentro. Dice che il tempo passa e che consuma – anche Petrarca e Laura la vita li ha separati per sempre. Ma dice che la bellezza dura, in una forma o nell’altra – e noi, infatti, siamo qui, a leggere queste pagine. Quando Petrarca e Laura si lasciano per sempre lo fanno in sogno. La morte – penso – non era stata altrettanto forte. Il sogno lo è di più. E qui? Che ne so io – penso – del Vesuvio, da cui (come scriveva Malaparte) una nuvola bianca sale «in cielo come un grande veliero» e che, mutevole come un tranello, un minuto dopo ti appare «tutto verde nel chiaror della luna […] verde come la faccia sfatta di un morto». Lo dichiarerò; ora glielo dirò a questi miei ragazzi che del Vesuvio io so soltanto ciò che ne ho letto, così come di tante altre cose. Che di Napoli so quanto ne ha scritto La Capria e Malaparte e Serao e l’Ortese e ci sono stato due giorni appena, in un inverno che la pioggia non finiva mai e inzuppava montagne di immondizia, perché era quell’anno in cui c’era la crisi dei rifiuti, la volta che ci passai, e le strade ne erano così piene che cercavi di evitare quelli più mézzi e lerci e ti adattavi a salire sugli altri, che parevano avere ancora una compattezza corporale, una forma, un’orma di ieri. Glielo dirò che, a differenza di loro, io di posti ne ho visitati due o tre appena e gli altri li ho scorsi, distratto e teso ed estraneo, come sfogliando una rivista nella sala d’attesa del dentista.

«…senza di loro, pensava Tonino, la gita al Vesuvio non si sarebbe mai fatta» legge Mary. «Erano piuttosto ruvidi nei modi, però, maneschi, e se litigavi con loro perdevano di colpo l’accento inglese e venivano fuori le maleparole in napoletano stretto…». E ci legge di Frank che diceva tutto quel che pensava e pure le offese. Giorno dopo giorno, si rimanda. Il Vesuvio è sempre lì, col suo cappuccio candido di neve «nell’azzurro ininterrotto»: si vorrebbe andare e non ci si va. Si lascia che il tempo passi. «Ma per quanto? – legge Mary, che una volta mi ha detto di voler fare teatro e ora, infatti, dà alla sua voce l’intonazione giusta e interpreta – Quanto avrebbe potuto durare con quelle giornate di sole che non pareva più di essere in inverno?». Si va o non si va? Tonino lo chiede a George: la neve non starà per sempre lassù ad aspettarli! Se si vuole fare la gita, con il bus e poi la ferrovia e la funicolare, così come si è detto, è ormai ora di andare. Mary dà voce a Tonino: «“Allora quando glielo chiedete questo benedetto permesso alla mamma?”» E il ragazzo inglese, George, che sa quel che sta accadendo nel mondo degli adulti, gli risponde con una smorfia – è ancora Mary a farlo rispondere – che è «“Meglio di no, […] ora ce l’ha con gli italiani, tutti”. “Che le abbiamo fatto?” domandò Tonino. “Siete tutti imbroglioni e ci avete traditi,” disse Frank facendosi rosso in viso. “E allora perché non ve ne ritornate in Inghilterra?” “Ce ne andiamo,” rispose Frank. “Non lo sai? Ce ne andiamo fra poco”». Frank non era arrabbiato, ma Tonino sì. «Non capiva. Non capiva chi aveva tradito, perché gli inglesi se ne andavano, che c’entrava tutto questo con lui, coi loro giochi, con la gita al Vesuvio e con la neve». Mary va avanti a leggere con la stessa delicatezza di prima; Susan non si distrae più col volo delle rondini: ha capito. Ron sta a testa bassa, sul libro, che ha tirato verso di sé. Lucy è tutta sbilanciata verso di lui e s’appoggia sulle braccia, abbandonate conserti sul banco, per poter sbirciare. Sì, ragazzi: è scoppiata la guerra. George, Frank, Margaret, Gordon, Tonino, Benito, Pepito, Pallino, Eddì avevano giocato tutto l’inverno e c’era stata la neve sul Vesuvio, come una magia. Avevano litigato, giocando, si erano spinti e spintonati e sbucciati ginocchia e gomiti. Come sempre. Avevano gridato e tirato sassi e il portiere del caseggiato era sopraggiunto minaccioso dal giardino, come ogni volta, quando le voci dei ragazzi diventavano chiasso e gli inquilini protestavano dalle finestre rivolte al cortile. Ma poi, guardando la neve – e chi di loro l’aveva mai vista la neve sul Vesuvio? – avevano pensato di dover far presto e correre, prima che se ne andasse. «“C’è la guerra. Tra poco gli italiani si metteranno contro gli inglesi, che erano amici”». È sempre Mary a dirlo, ma pare ci sia Frank che minaccia sulla faccia di Tonino. Gli adulti si fanno la guerra; devono odiarsi, ora, anche i ragazzi. «“La più schifa sulla terra è sempre stata l’Inghilterra, lo sapevi?”. Questa frase non era sua, Tonino non l’aveva mai pensata. L’aveva vista scritta sui muri, o sentita cantare da qualche scalmanato. Chissà come gli era salita alle labbra in quel momento, si domandò. E gli parve che qualcosa di grande e mostruoso, qualcosa che loro stessi non conoscevano, li stesse manovrando». E, infatti, Tonino e Frank che avrebbero voluto andare insieme a giocare con la neve, sulle immacolate pendici del Vesuvio, cominciano a scazzottarsi «… e mentre volavano i pugni capì che era tutto finito, che ogni gioco era finito per sempre. E c’era solo l’odio, adesso, e il sangue che colava dal naso».

«Sei stanca, Mary?», le chiedo.
«No, no», si affretta a dirmi Mary. Scuote la testa, i suoi capelli castani, mossi e lucidi fin sulle spalle. Vuole finire lei. Legge da oltre mezz’ora, ma vuole essere lei a far scorrere fino alla fine le parole del racconto e appoggia tutte e due le mani sul libro, sforzandone la legatura in mezzo, trae un respiro, riparte a voce più ferma: «Partirono senza farsi più vedere, senza salutare nessuno dei ragazzi. E cessarono di colpo le grida che ogni giorno salivano dal cortile. Finirono le belle giornate che erano durate fin troppo quell’inverno. E la gita sul Vesuvio non si fece più, anche perché la neve intanto era sparita, e chissà quando sarebbe riapparsa un’altra volta».
Mary mi guarda. È soddisfatta e triste. Tutti mi guardano, ora, si aspettano che io concluda. Rintocca la prima campana di mezzogiorno: è Sant’Andrea, anticipa sempre di cinque minuti e ora so che tanti me ne restano. «Che ne dite? È meraviglioso, non è così? Semplice e puro. Ci vogliono anni e anni di lavoro per scrivere con questa semplicità. L’avete notato? Ci si arriva per via di levare. Anzi, per via di levigare. Togli tutto quello che non serve e poi smussi quello che serviva, ma che ti sei accorto che ti piaceva troppo – e non sei tu che scrivi che ti devi innamorare di ciò che scrivi. La neve del Vesuvio è un’opera di Raffaele La Capria, uno dei più grandi, forse il più grande, scrittore italiano vivente. Leggetelo. La neve sul Vesuvio è un fatto raro. Ma un inverno che è quasi un’estate, dice la novella, prodigiosamente, il Vesuvio se ne copre. Lì sotto, a Napoli che, come vi dicevo il Vesuvio sempre guarda, alcuni ragazzi giocano fra loro. Sono adolescenti e vivono sospesi, come tutti gli adolescenti, tra la fascinazione magica dell’infanzia, la scoperta della forza del loro corpo, le avvisaglie dell’età adulta, le precoci simpatie, le tracce dell’amore che sarà. Alcuni sono italiani, altri sono inglesi, ma niente importa e ogni giorno giocano insieme, nello stesso cortile e, vedendo la neve che ha coperto il cono del Vesuvio, insieme progettano di andarci. Poi, però, scoppia la guerra. Ricordate che l’autore ci ha detto all’inizio? siamo nel 1939. Scoppia la guerra, che non è affar loro, ma affare degli adulti, e i ragazzi ne vengono coinvolti. Erano amici e la guerra, di cui hanno sentito parlare gli adulti, li divide. Si insultano, quando non vorrebbero, si picchiano. Gli adulti si sono dichiarati guerra e loro, che non ne sanno niente, anche se niente dovrebbe importargli, la guerra se la fanno prima degli adulti. Si sputano addosso, si tirano pugni e calci. Altri hanno deciso che devono essere nemici. Ma è stato deciso anche che la loro infanzia è finita e che, da ora in avanti, saranno adulti. Quando si voltano, sul Vesuvio, la neve non c’è più. Niente più magia dell’infanzia, niente più sogni. E noi?». Tornavo a sorridere: «Anche noi ci lasciamo. Grazie, ragazzi, per il lavoro che abbiamo fatto insieme. Sono contento di voi. Noi ci lasciamo da amici. Tenetevi stretti i vostri sogni; teniamoci stretti i nostri sogni. La vita è sogno: forse. Tenetevi stretti i vostri sogni, che sono la vostra vita. Buona fortuna, ragazzi».
Ci si salutava così, a fine maggio, a Padova, quando chiudevo il corso di letteratura italiana contemporanea. E i miei studenti, ormai amici, mi stringevano la mano. Affettuosamente ci lasciavamo, andandosene ciascuno alla propria vita e ai suoi sogni. E c’era un po’ di commozione ad aver letto di quella neve sul Vesuvio, liquefatta come tutte le migliori intenzioni, quando lasciano il passo alla guerra; e c’era ormai un fremere di energia diffuso, perché, io tanto quanto loro, sapevamo di dover presto partire per un nuovo pezzo di vita (e fu sempre così, tranne quella volta che, dalla finestra aperta entrò per un istante un’audace rondinella, impaurita e garrente, e ruotava le ali, mentre sfiorava il soffitto; poi, dopo due giri d’aula, cercando lo sbocco dove aveva trovato l’imbocco, se ne tornò, lieta e leggera, nel profumato cielo di primavera, colmo di calore e di ronzii).
***
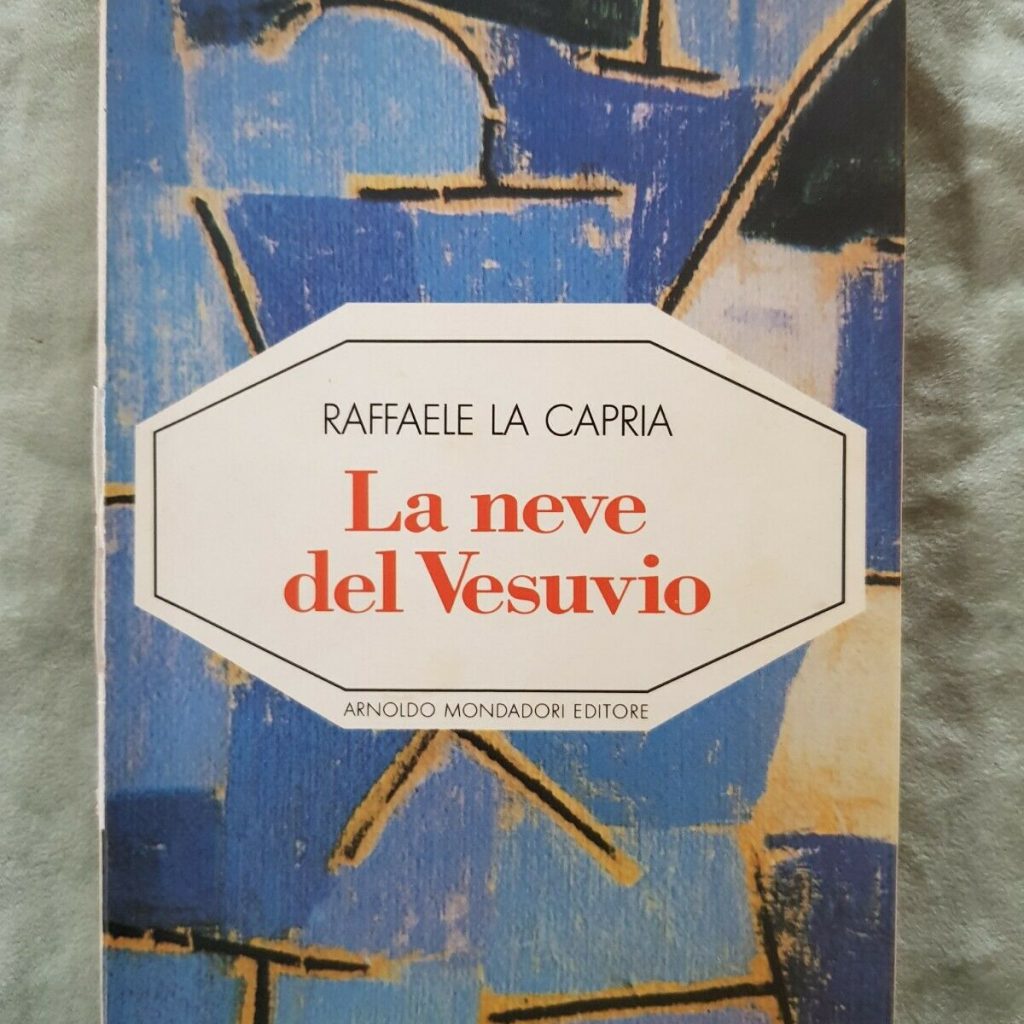
«Va bene», mi disse. «Vengo».
Alla Mondadori mi avevano suggerito di scrivergli una lettera. «Se vuole, può farlo via fax», avevano aggiunto. Stavo organizzando il ciclo «Viaggiar per Storie», per la Fondazione Garrone di Genova, in collaborazione con il Palazzo Ducale. Avevo pensato a Raffaele La Capria. Di Raffaele La Capria avevo letto tutto, una, due, tre volte. Giorgio, caro amico, ordinario di letteratura italiana a Genova, che a La Capria aveva dedicato studi e che sempre, mandandogliene copia, ne aveva ricevuto elegantissime risposte, mi aveva dato coraggio: «ma certo. Scrivigli», mi aveva detto. «Sarebbe bellissimo se accettasse di venire». E così avevo preso carta e penna. Come farò a convincerlo?, pensavo. Come farò, in una lettera formale, di mezza pagina, trasmessa via fax, a chiedergli di venire qui, a Genova, al Palazzo Ducale, per uno degli incontri del nostro ciclo? Dovrò, forse, fargli intendere di essermi nutrito dei suoi libri? E scrivere – magari – con allusione sorniona che, in questa città di feriti a morte, stanchi di false partenze, noi siamo impazienti di ritrovare l’armonia o che la bellezza di Genova vorremmo fosse lui a dircela, così come quella di Napoli e di Roma, e che a Genova, come a Napoli, c’è la terra e c’è il mare e l’una e l’altro vanno salvati e che non si fa, niente si può fare, senz’estro quotidiano? Anche i più grandi non sfuggono alla lusinga sottile di chi, avendoli letti, manifesta loro la sua ammirazione. Chi ti legge, ti dà il suo tempo. Chi legge un tuo libro, ti fa dono di tre, quattro, cinque, dieci, venti… (dipende dalla lunghezza) ore della sua vita. Davvero non è poco e lo scrittore, uno scrittore che sia grande, non lo dimentica. Io, però, mi chiedevo che avrei dovuto scrivere? E come? Dovevo scrivere riconoscente (per tutto quello che avevo letto di lui) e riconoscibile (perché capisse che l’avevo letto), oppure no: semplice semplice, “per via di levare”, come doveva piacere a lui…?
Scrissi e, due giorni dopo, il mio telefono suonò: «Pronto, buongiorno, sono Raffaele La Capria».
Gli spiegai il mio desiderio e il mio progetto: il viaggio, i suoi libri, Genova, il Palazzo Ducale. Mi disse semplicemente: «Va bene. Vengo». Ero felice.
Ma, poi, due giorni dopo, mi richiamò: «Mi dispiace. Non me la sento». Insistere non si poteva e poi, anche nel ritrattare e sottrarsi a quel nostro invito, di cui ero stato il più fermo e fervido portatore, era di una gentilezza affabile, quasi miracolosa. «Mi dispiace» diceva «spero di non metterla nei guai». «Ma no, me la caverò. Capisco. Anzi, grazie in ogni modo». E gli dicevo che avrei continuato a leggerlo, proprio così come avevo sempre fatto, tenendomi accanto quelle sue parole, di amico ormai per me intimo. Bene così, dicevo. Me la caverò, dicevo. Però avevo un ultimo desiderio. Tutti abbiamo un ultimo desiderio, che è quello che si concede quando la speranza di ottenere la grazia è sfumata e non la si chiede nemmeno più e nemmeno più ci si prova a chiederla, ma si lascia piovere un ultimo desiderio, che per solito, a confronto con la richiesta della grazia è una sciocchezza, e al quale non si può dire di no: un’ultima sigaretta, un bicchiere di vino speciale, un buon pasto caldo, quel tacchino con le castagne che ogni Natale ci cucinava una prozia da parte di mio padre e che vorrei riassaggiare per ritrovarmi, rimasticandolo, innocente e bambino dopo tutti questi quaranta e passa anni di malaffare… e così via. «Per combinazione – dico – domani sono a *** per un lavoro. Se fosse per lei di non troppo grande disturbo e senza voler in alcun modo mettere scompiglio nella sua giornata, sarei immensamente felice se potessi salutarla un momento, di persona. Mi concede di farle visita?». «Ma come no!» mi risponde con l’affabile cortesia del vecchio gentiluomo. «Con grande piacere». E mi dà il suo indirizzo, al quale restiamo intesi che mi presenterò intorno a mezzogiorno.
Suono alla porta di Raffaele La Capria l’indomani, a mezzogiorno e due minuti. Chi mi arriva in anticipo, quando gli do un appuntamento, a me che sono sempre di corsa, crea qualche fastidio. Mi figuro che sia un po’ come me. Due magrissimi minuti, uno e mezzo forse, sono un intervallo giusto, mi pare: si è puntuali senza per questo rischiare di sorprendere il nostro ospite mentre sta ancora facendo altro o senza costringerlo a interrompersi. Non mi piace imporgli di dover prendere le misure dei minuti, penso. E poi è una visita di cortesia, non un appuntamento business, quando un po’ di anticipo o la più scandita delle puntualità sono dovute. Anticipo o eccesso di puntulità sarebbero rigidezza, impaccio, settentrionalità. E, infine, – penso – sto per far visita a un uomo che con il tempo ci ha fatto i conti e che lo ha raccontato quasi come nessun altro. Due minuti. Sono trascorsi due minuti da mezzogiorno quando varco la soglia di casa di Raffaele La Capria e il suono delle campane della città ancora entra, dalle finestre mezzo aperte del suo attico. Lo ringrazio, sono emozionato. Nella borsa ho molti dei suoi libri. Gli dico – ed è vero – quanto sia felice di incontrarlo, dopo tutto quel tempo che ho passato con lui, per mezzo dei suoi libri. «Mi dispiace, sa – mi ripete – non venire a Genova. Me l’ha detto che ci teneva, è gentile, ma…». Lo rassicuro, ho capito, va bene così, non se parli più: sono contento di essere lì e tanto mi basta. «Ho una curiosità», mi chiede quando stiamo per salutarci. «Mi ha detto che le conferenze, gli incontri con gli autori, tratteranno del viaggio… perché non, per esempio…? insomma, io non mi ritengo uno scrittore di viaggio. Perché ha pensato a me?»
«Forse perché ho cominciato a leggere i suoi libri – e l’ho fatto, più di una volta – proprio mentre ero in viaggio. Proprio durante un viaggio – benché io ne abbia fatti pochi», comincio. «Ma non è per questo soltanto. Anzi, non è proprio per questo… C’è stato un periodo della mia vita – racconto – in cui ho insegnato. Insegnavo letteratura italiana contemporanea a Padova, nella sede italiana di Boston University. L’ho fatto fino al 2009. Il corso era semestrale, finiva a maggio e l’ultima lezione, con i miei studenti, leggevamo ogni volta La neve del Vesuvio. Leggevamo di quel miracolo imprevisto della neve, che è magia e prodigio, dei ragazzi italiani e inglesi che giocano fra loro e intanto progettano di salir su, fino al Vesuvio, e toccare quella neve che cade tanto di rado lassù. E passa il tempo e la neve pare aspettarli – anche se loro temono che scompaia e di giorno in giorno, con quel timore, spiano il Vesuvio per essere sicuri che ancora ci sia. Poi scoppia la guerra. Loro con la guerra non c’entrano per niente. La guerra la fanno gli adulti e loro non ne sanno né le ragioni né le motivazioni. Però, soltanto perché gli hanno detto che è giusto fare così, anche i ragazzi, che fino al giorno prima erano amici e progettavano la loro gita sul Vesuvio, per toccare la neve e giocarci, cominciano a odiarsi. Fanno a pugni, fanno, anche loro, la guerra. Ed è allora che si accorgono che la neve che pareva averli aspettati, cioè il sogno meraviglioso e spensierato dell’infanzia, come d’un colpo, si è dissolta, è sparita. Non c’è più. L’infanzia è finita, la spensieratezza è finita, la gioia possibile è finita. Tutto è finito. Noi leggevamo ogni volta quel racconto e, quando finiva, così come Tonino e George e Frank Benito e Pepino si lasciano per sempre, anche per noi, per me e per i miei studenti, era finita. Era l’ora di salutarsi e ci salutavamo. Non in guerra, ma in pace, da amici. Ciascuno tornava alla propria vita, le nostre strade si separavano. Il nostro tempo di magia – perché lavorare insieme per vedere meglio, per capire meglio, per sapere di più, è sempre una magia – si era concluso. Sì, credo che sia per questo. È per questo che ho pensato che mi sarebbe immensamente piaciuto e sarebbe stato appropriato se lei fosse venuto a Genova per questi nostri incontri».
Raffaele La Capria mi aveva ascoltato, ora sorrideva. «Vengo» mi disse.
E così il 30 maggio 2012 Raffaele La Capria fu a Genova, ospite di FEG, a Palazzo Ducale, per il ciclo “Viaggiar per Storie”. Fu meraviglioso. Memorabile.
Stefano Termanini (26 marzo 2022)
N.B. Questo racconto è un omaggio a Raffaele La Capria, maestro insuperabile di scrittura, che guarda alla letteratura italiana dall’alto del suo centesimo anno d’età. Ed è una riflessione sulla guerra, che uccide la vita e il suo sogno. Voglio sia dedicato ai miei allievi di Boston University CIES, Padova: sono sparsi per il mondo. Spero siano intenti a far crescere i loro sogni e a coglierne il frutto.